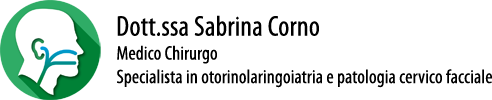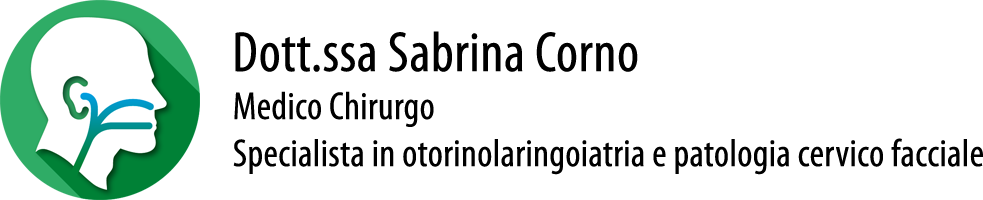Cosa è la disfonia?
Cosa è la disfonia?
La disfonia è una alterazione qualitativa e/o quantitativa della voce parlata che consegue ad una modificazione strutturale e/o funzionale di uno o più organi coinvolti nella sua produzione o ad una inadeguatezza delle relazioni dinamiche fra le diverse componenti dell’apparato pneumo-fonatorio.
Le strutture anatomiche essenziali per generare il prodotto acustico vocale (suono periodico complesso) sono: il mantice polmonare che genera la corrente aerea espiratoria e deve fornire flussi e pressioni adeguati, la laringe che attraverso la vibrazione (componente bio-meccanica) e l’ondulazione della mucosa (efetto Bernoulli) genera l’energia sonora, le cavità sopraglottiche che modificando volumi, forma e caratteristiche di risonanza delle pareti sono in grado di influenzare la distribuzione dell’energia nello spettro vocale.
Su questi efettori periferici il sistema nervoso con diversi livelli di coinvolgimento in rapporto ai vari aspetti della produzione vocale esercita una funzione di programmazione, attivazione e
controllo.
Qualsiasi alterazione anatomica o funzionale di questi molteplici distretti determina un disordine vocale.
A tuttora non esistono razionali classificazioni ed elencazioni dei quadri clinici di disfonie.
Come si diagnostica la disfonia?
È inoltre necessario definire le modalità per il riconoscimento e la diagnosi dei vari tipi di disturbo vocale utilizzando indagini il più possibile obiettive e tecnologie non eccessivamente sofisticate e quindi disponibili dalla maggioranza degli addetti ai lavori.
Fra i numerosi strumenti a disposizione segnaliamo come essenziali: anamnesi e valutazione delle modalità e del contesto d’uso della voce, videostrobolaringoscopia con registrazione delle
immagini utilizzando fibroscopi rigidi (ottimale definizione delle lesioni organiche) e flessibili (indispensabili per cogliere gli atteggiamenti muscolo-tensivi della laringe ed eventuali disturbi deglutitori associati alla disfonia), analisi elettroacustica (M.D.V.P., fonetogramma), indici aerodinamici (T.M.F., Q.F.).
In alcuni casi di immobilità laringea può essere indispensabile, per una diagnosi diferenziale, l’elettromiografia e talvolta per confermare il sospetto di una patologia da reflusso gastro-esofageo una ph-metria ed un’esofagogastroscopia.
Una prima difcoltà nel progettare un modello classificativo è l’identificazione delle categorie principali:
la classica suddivisione che prevede le disfonie miste accanto alle organiche e alle funzionali (o disfunzionali) non riproduce in modo adeguato la realtà delle diverse situazioni cliniche la cui evoluzione comporta pressoché costantemente il passaggio da una categoria all’altra con un diferente peso delle due componenti (organica e disfunzionale) nel quadro sintomatologico dei singoli pazienti.
È sicuramente più utile da un punto di vista pratico una classificazione che preveda due “gruppi principali”: disfonie organiche (sono presenti alterazioni morfologiche o neuromuscolari di uno o più organi od apparati implicati nella produzione e nel controllo della voce) e disfonie non organiche o funzionali (assenza di lesioni e di turbe motorie).
Nel valutare un paziente con una disfonia organica bisognerà porre attenzione alla componente disfunzionale che, tranne pochi casi diagnosticati in fase di esordio, è sempre presente e condizionerà la pianificazione terapeutica.
La dott.ssa Sabrina Corno, Otorinolaringoiatra, si occupa di Disfonia a Milano, Patologia dell’Orecchio, del Naso e della Gola a Milano, Monza e Brianza presso lo Studio Medico Otorino Milano in Piazza Corte Grande 27, Gessate.